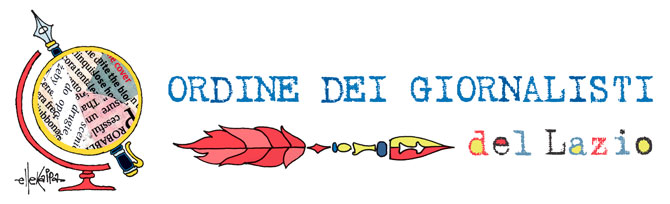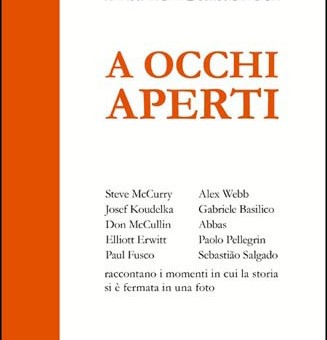
Quando Mario Calabresi lo intervista (e già questa è una notizia, perché il fotografo della Primavera e dell’inverno di Praga è notoriamente schivo e laconico), prima di rispondere Josef Koudelka apre uno dei suoi libri, cerca l’immagine giusta e la studia: «Non ti puoi fidare della memoria, ma delle foto sì, ti puoi fidare».
E questa, anche a molti fotografi, sembreràun’affermazione ormai fuori corso, il residuo di un’era in cui i fotoreporter erano sicuri di sé e del proprio ruolo, erano ancora, come li chiama un loro amico e critico, il mediologo Fred Ritchin, «fotografi intrepidi», eroi della visione, sguardi delegati dell’umanità sul mondo, cavalieri di ventura in missione per conto dell’occhio collettivo.
Mentre quella che viviamo sarebbe l’epoca dei fotografi insicuri, dubbiosi, emarginati dai mainstream media, messi nell’angolo dall’ubiquità della smartfonografia.
E forse c’è del vero, ma il fotogiornalismo è già ufficialmente morto troppe volte per essere morto davvero. Qualcosa nelle sue fondamenta deve essere solido, e di questo va in cerca Calabresi in un libro, A occhi aperti, che è più della somma delle sue parti, ovvero dieci interviste a dieci nomi che risuonano sulla scena e nella storia del fotoreportage contemporaneo.
Qualcosa che ha a che fare con «la malattia di esserci quando le notizie fanno la storia», ed esserci, per un fotografo, significa obbedire al primo e unico comandamento del Mosé dei fotorerporter, Bob Capa, che i suoi discepoli portano tatuato sul cuore: «Se le tue foto non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino».
Significa obbligatoriamente essere lì, col corpo, immersi fino alla cintola nell’acqua sporca degli eventi, come Steve McCurry (uno che passa, un po’ sbrigativamente, per essere un fotografo “facile”, popolare, da effetto) nel fango del monsone indiano del 1983, dove rischiò di affogare quando un ponte gli crollò sotto i piedi.

Gabriele Basilico, Beirut 1991 © Gabriele Basilico, g.c.
Significa ripetersi «scatta, dài, scatta»come Paul Fusco salito al volo sul treno che portava a Washington la bara di Bob Kennedy, quando davanti ai finestrini, dai bordi della massicciata, gli si parò un’incredibile America multietnica e interclassiata con la mano sul cuore, significa anche tenere quelle foto nel cassetto per anni, incomprese, e finalmente poterle esporre: «Non buttare mai via quello che scrivi, servirà», raccomanda al suo intervistatore.
Significa avere uno sguardo ironico sul mondo, avere in tasca la trombetta per far sobbalzare cani e umani e catturarli con la guardia abbassata, come Elliott Erwitt, ma saper sobbalzare come quando scoprì di avere davanti la notizia: i missili sovietici in parata che solo lui fotografò nel ’57, e che cambiarono la temperatura della guerra fredda.
Innamorato della fotografia dall’età di dodici anni, Calabresi è oggi giornalista, direttore della Stampa, e la sua inchiesta attraverso gli occhi dei fotografi è, in realtà, una lunga domanda sul giornalismo, sulla necessità della testimonianza, minacciata dalla frana della ridondanza e dell’autoreferenza di una grande Rete che parla sempre più spesso e solo della Rete.
Ai suoi dieci cavalieri dell’obiettivo rotondo, ha chiesto cosa succede quando l’occhio del testimone professionale incontra la storia: come riconoscerla, come prenderle un calco, come colarla in un oggetto visivo che sia utile a chi lo vedrà.
Le storie che i fotografi raccontano, le parole attorno alle loro immagini, al prima e al dopo il momento dello scatto, non sono che diverse risposte alla domanda, generose confessioni e spesso dolorose: le parallele esperienze d’esilio di Koudelka dalla sua Praga e di Abbas dalla sua Teheran fanno parte, a pieno diritto, del loro modo di raccontare anche tutto il resto.
Il fotografo è sempre dentro l’inquadratura. Se è una finestra sul mondo, il suo volto si riflette un po’ sul vetro. La risalita alle origini primordiali del mondo di Sebastião Salgado non è l’opposto delle sue narrazioni epiche della fatica umana, ma la conseguenza, la riparazione simbolica.

Abbas, Afghanistan, 1992 © Abbas/Magnum Photos, g.c.
Il fotografo è sempre stato l’esploratoredell’ignoto: sul confine maledetto fra Messico e Usa Alex Webb cerca «quel che non mi aspettavo». A volte quel che non ti aspetti può anche essere una granata, quella che risparmiò Paolo Pellegrin nel Libano del sud. «Fotografo è l’unico titolo che mi serve», rivendica Don McCullin stanco di guerre ma non di visione.
Fotografi e basta? C’è in effetti un fotografo che non ti aspetti nel panel di Calabresi, che non corrisponde al modello del reporter di guerra: è Gabriele Basilico, fotografo col treppiede, esploratore lento di paesaggi urbani, un «misuratore dello spazio», si definisce, anche quando è lo spazio devastato di Beirut in macerie.
Ma ecco che anche Pellegrin, con tutte le sue immagini di dolore estremo, si definisce quasi allo stesso modo, «un catalogatore». E non è cinismo, è un modo di rifondare il proprio ruolo: il fotografo intrepido fornitore di risposte è finito, il fotografo utile cercatore di domande è ancora tra noi. E ci serve ancora.
Michele Smargiassi – La Repubblica.
Link all’articolo: http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/12/06/cosa-dobbiamo-ancora-vedere/
A occhi aperti – Mario Calabresi – Contrasto editore
4.974 visite