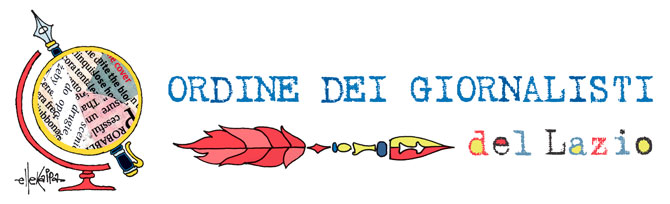«Mi hanno preso con sei macchine, mentre portavo aiuto ai miei amici in carcere. Mi hanno condotto in una piccola cella. Mi hanno legato le mani dietro la schiena e buttato in testa un secchio di acqua ghiacciata. Poi hanno collegato la corrente elettrica. Sono stato ventuno giorni al buio, senza contatti con l’esterno. I primi due senza mangiare né bere, i successivi solo con un pasto al giorno. Mi hanno torturato tutte le notti. Ogni volta la stessa domanda, “chi vi aiuta?”, “quali governi vi sostengono in questo vostro lavoro?”. Io però non capivo per quale motivo mi trovavo lì e di cosa ero accusato. Mi hanno chiesto se ero a conoscenza dei sette capi di imputazione, tra i quali quello di terrorismo. Io però non c’entravo nulla, non sapevo nulla. Dopo tre settimane mi hanno portato nel carcere centrale con altri giornalisti e con veri terroristi. Ho subìto sette mesi di carcere preventivo, senza processo. I miei avvocati sono stati minacciati, non dovevano difendermi perché ero un terrorista. Alcuni dei colleghi sono stati rilasciati con cauzione, io sono rimasto dentro, insieme ai miei compagni. Sono stato rilasciato dopo otto mesi perché le accuse erano infondate. Dopo tre giorni fuori dal carcere, però, sono stato di nuovo arrestato. Me lo hanno detto e ripetuto: la prossima volta non ti aspetta la prigione, ti eliminiamo».

Ha la voce serena, ma i segni del dolore fisico e il ricordo delle umiliazioni subite emergono dai suoi occhi. Mohamed Bashir Hashi (nella foto a sinistra), 26 anni, è uno dei cinque giornalisti somali di Radio Shabelle perseguitati, processati e condannati per aver raccontato verità scomode al potere politico del loro Paese.
Insieme ai suoi compagni, Ahmed Abdi Hassan, Mohamed Abdullahi Jama, Mohamed Abdi Warsame, cronisti e conduttori di una delle poche voci libere di Mogadiscio, è riuscito a raggiungere l’Italia, dove chiederà asilo politico. Il collega Abdimalik Yusuf Mohamud, invece, non è riuscito a lasciare il Paese. Il loro arrivo è una vittoria a difesa della libertà di stampa ottenuta grazie all’Ordine dei giornalisti del Lazio e alla Federazione nazionale della stampa italiana, con l’interessamento del Ministero degli Esteri e dell’Associazione Migrare, che dopo mesi di lavoro diplomatico sono riusciti ad ottenere i visti di uscita da Mogadiscio.
Mohamed Bashir Hashi e i suoi compagni fuggono da uno stato lacerato da conflitti interni, in cui le forze governative da una parte tentano di combattere i terroristi di Al Shabaab, dall’altra reprimono ogni libertà di espressione e di informazione. Tra il 2007 e il 2013 nella sola Radio Shabelle sono stati uccisi 12 giornalisti, molti altri sono stati fermati, processati e portati in carcere semplicemente per aver svolto il proprio lavoro di cronisti. Nell’ultimo anno Radio Shabelle e Sky Fm sono state chiuse tre volte con il sequestro di tutti gli impianti.
«Negli ultimi otto anni sono stati uccisi quaranta giornalisti - racconta Mohamed -. La nostra è una realtà dura, che spinge molti somali a fuggire e a venire in Europa in cerca di salvezza. Siamo continuamente al centro di violenze e azione repressive da parte della polizia, che arriva di notte, a casa, e ti porta via. Nessuno vuole che la popolazione venga informata, che la libertà di stampa possa nascere anche nella nostra terra. Ed è per questo che la Somalia si è trasformata in un paese dove l’Isis trova consensi e reclute».
Mohamed racconta di essere finito nel mirino degli Shabaab e dei servizi di sicurezza governativi per aver diffuso la notizia del dramma vissuto da Fadumo Abdulqadir Hassan, una giornalista di Kasmo Radio (la voce delle donne) violentata da due esponenti della Polizia politica somala, mai processati. La storia di Fadumo, licenziata dopo aver denunciato l’accaduto, ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Italia, dove la donna ha trovato accoglienza e asilo politico.
 Ora altri cinque colleghi somali si trovano nel nostro Paese a testimoniare, con le loro storie, che “la libertà di stampa non ha confini”. «Nei momenti di grande difficoltà, quando eravamo in carcere – racconta Mohamed – l’associazione dei giornalisti di Mogadiscio ha fatto comunicati di condanna, ma non poteva fare molto di più, perché la pressione delle forze governative è forte. L’aiuto maggiore è arrivato da giornalisti che vivono all’estero. Ed è anche grazie e questo che oggi siamo qui a raccontare quello che accade in Somalia, sperando di poter tornare, un giorno, nella nostra terra, finalmente libera».
Ora altri cinque colleghi somali si trovano nel nostro Paese a testimoniare, con le loro storie, che “la libertà di stampa non ha confini”. «Nei momenti di grande difficoltà, quando eravamo in carcere – racconta Mohamed – l’associazione dei giornalisti di Mogadiscio ha fatto comunicati di condanna, ma non poteva fare molto di più, perché la pressione delle forze governative è forte. L’aiuto maggiore è arrivato da giornalisti che vivono all’estero. Ed è anche grazie e questo che oggi siamo qui a raccontare quello che accade in Somalia, sperando di poter tornare, un giorno, nella nostra terra, finalmente libera».
Mohamed ha lanciato un appello alla comunità internazionale e, in particolare, all’Italia, chiedendo di non essere lasciati soli. «In questi giorni abbiamo rilasciato interviste e abbiamo ricevuto telefonate di minacce. Ci dicono che se interveniamo ancora sulla politica del nostro stato pagheremo noi e le nostre famiglie. Denunciando quello che accade è come se avessimo fatto un danno alle nostre madri, alle nostre mogli, ai nostri figli».
Parole che non lasciano spazio all’immaginazione sul clima che si respira in Somalia, uno stato al 172° posto su 180 nella classifica 2015 sulla libertà di stampa stilata da Reporter senza Frontiere. Parole con le quali questi cinque ragazzi somali hanno sempre esercitato, pagandolo a caro prezzo, il “diritto ad informare”, ieri dalla loro emittente radiofonica, oggi davanti ad una folta platea di colleghi italiani. Giornalisti che hanno ascoltato le loro voci e le loro storie in occasione del corso di formazione “Migrazione: dalla globalizzazione alle separatezze” promosso dall’Ordine del Lazio. Un’occasione per fare tesoro di esperienze che sembrano lontane dalle nostre ma che in realtà non solo ci toccano da vicino ma ci obbligano a non restare indifferenti.
Giovanna Sfragasso, consigliera Ordine dei giornalisti del Lazio
3.659 visite